Dopo Liberami, premiato con il Leone come Miglior Film nel Concorso Orizzonti alla settantatreesima Mostra del Cinema di Venezia, Federica Di Giacomo torna nel 2021 al festival con un documentario in cui, ancora una volta, si avventura in una realtà nascosta ai più, riuscendo a farne emergere la dimensione universale.
Il palazzo suggerito dal titolo è un edificio situato a Roma, vicino San Pietro, messo a disposizione da un eclettico mecenate a tutti coloro che intorno alla metà degli anni Novanta volevano fare un’esperienza diversa di vita, in cui la soglia tra arte ed esistenza si assottigliava fino a svanire.

“Ho iniziato a frequentare il Palazzo molti anni fa. Un microcosmo di rara libertà creativa ma completamente avulso dalla realtà. Avevo da poco iniziato il film quando Mauro improvvisamente morì. Durante la sua commemorazione sentii che ognuno di noi si stava segretamente comparando all’amico scomparso, cercando di capire quanto avessimo in comune con lui e cosa invece ci potesse distanziare da un destino così amaro. L’immenso archivio che Mauro ha lasciato costruisce il rapporto fra la nostra immagine e quella che il passato ci restituisce attraverso la memoria orale e visuale dei nostri amici. Tutto il gruppo, infatti, ha già recitato per Mauro e in un certo senso recita se stesso anche per me, questa volta senza copione, con grande autoironia in un gioco fra realtà e finzione” dichiara la regista.
Mauro Fagioli, che più degli altri s’immerse in quel contesto atipico, è il personaggio intorno a cui, dopo il prematuro decesso, si riuniscono quanti, anni prima, avevano vissuto un modo di “essere nel mondo” alternativo, che contestava tacitamente la monotonia del quotidiano, quel rigido ordine simbolico in cui per lo più siamo tutti fatalmente catturati.

La regista, che conosceva personalmente l’ambiente, avendolo frequentato, è abile a far sprofondare lo spettatore in una dimensione di sospensione, che si potrebbe definire del “gesto mancato” o, se preferite, “a vuoto”. Sì, perché tutto quel fermento che si visse in quel periodo non confluì in una realizzazione concreta, una o più opere che, in un certo senso, attestassero il risultato di un atto creativo. Mauro, nella fattispecie, per anni girò un film con tutti gli inquilini del palazzo, producendo un mastodontico materiale che non ha mai trovato un compimento, un montaggio finale, un epilogo. Insomma, utilizzando il gergo aristotelico de La metafisica, Di Giacomo indugia coraggiosamente sulla Potenza che si ostina a non diventare Atto.
La temporalità di questo nebuloso intervallo non è cronologica, non può essere misurata, piuttosto coinvolge nel profondo tutti coloro che vi sono sprofondati, senza che di essa possa essere fornita una testimonianza precisa, storica, laddove mancano tracce sicure ed evidenti che consentano di procedere a una ricostruzione esatta. Ed è per questo che, ancor di più, è apprezzabile il lavoro della regista che, coscientemente, ha deciso di confrontarsi con “l’ineffabile”, con qualcosa che eccede la possibilità della rappresentazione, in un corpo a corpo tra cinema e ciò che non si manifesta in quanto fenomeno. Il palazzo non è, quindi, solo il reportage di un’esperienza particolare, piuttosto il coraggioso tentativo di evocare l’invisibile, segnalandolo, rintracciandone l’eco, chiamando a raccolta tutti coloro che lo attraversarono.

Chi scrive, avendo anch’esso conosciuto tangenzialmente quel mondo e quell’umanità, ammette di esser stato fortemente scosso dalla visione del film: la facoltà di Filosofia dell’Università di Roma La Sapienza fu il serbatoio che fornì il panorama umano della vicenda raccontata. E chi proveniva da lì aveva cuore puro e un desiderio autentico, e magari anche ingenuo, di giungere a una Verità che gli concedesse una tregua, che gli fornisse qualche strumento in più per restare a galla nella palude asfittica del quotidiano.
Questi eroi misconosciuti e silenziosi hanno provato a “deterritorializzarsi”, cercando di smarcare, per dirla con il linguaggio deleuziano de L’Antiedipo, l’opprimente muro semiotico del capitale. Ma, è bene subito chiarirlo, non ce l’hanno fatta. Non sono riusciti, cioè, a trasfigurare l’ordine simbolico dominante, a dare corpo a una situazione atipica che venisse riconosciuta. Ma non è un biasimo questo. È un’impresa titanica portare a termine tale movimento e solo il fatto di averci provato è degno delle più accese lodi. Quegli anni e quell’attività “improduttiva” restano però indelebilmente impressi nell’animo di chi ne fu protagonista, di chi ebbe l’ardire di provare a non essere “sussunto”, “mangiato”, avrebbe detto Pier Paolo Pasolini. E chi può dire con certezza che essi abbiamo fallito? E se invece fosse vero il contrario? E se la vera sconfitta fosse stata piuttosto rassegnarsi, senza far alcuna resistenza, a diventare anonimi consumatori di merci, privati della propria soggettività, in nome del lavoro, della famiglia, dell’interesse generale di un paese che non ama i propri figli?
Luca Biscontini

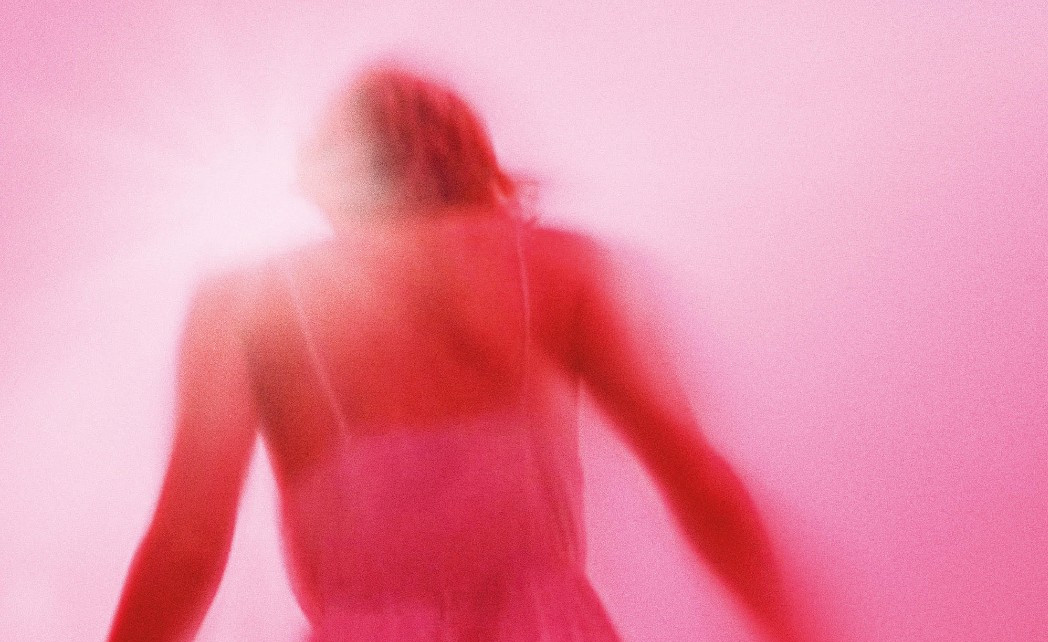



![Arriva l’Hip Hop Cine Fest 2024 Roma si appresta a diventare il palcoscenico internazionale della quarta edizione del Festival Internazionale del Cinema Hip Hop, evento dedicato alla produzione cinematografica che si ispira e utilizza l’Hip Hop […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Hip-Hop-Cine-Fest1-115x115.webp)
![Al cinema Il caso Josette, con Dany Boon e Jérome Commandeur Nei cinema italiani da oggi, 24 Aprile 2024, Il caso Josette, diretto da Fred Cavayé. Ne sono protagonisti Dany Boon e Jérome Commandeur. Francia, 1640. L’avvocato Maitre Pompignac non ha mai […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-caso-Josette-115x115.webp)
![Al cinema Challengers, diretto da Luca Guadagnino Dal regista Luca Guadagnino arriva nelle sale cinematografiche italiane oggi, 24 Aprile 2024, Challengers. Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Io sono l’amore) ha diretto il film da una sceneggiatura di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Challengers-115x115.webp)
![Arriva al cinema La moglie del Presidente, con Catherine Deneuve Una sorprendente Catherine Deneuve torna sul grande schermo nel ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero La moglie del Presidente. Diretta, al suo esordio, da Léa Domenach, La moglie del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/La-moglie-del-presidente-115x115.webp)
![Arrivederci Amore, Ciao di Michele Soavi “Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù /Cercavo in te la tenerezza che non ho/La comprensione che non so trovare in questo mondo stupido… Quella persona […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/CiaoOr-115x115.webp)
![Jericho’s tail (La coda di Jericho): nel porno, tra Orwell e rivoluzione sessuale Jericho’s tail (La coda di Jericho) è il lungometraggio d’esordio di Marcello Caroselli, che ne ricopre anche il ruolo di protagonista: un ragazzo sui trent’anni italo inglese, di nome Jericho […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHO-POSTER-PRIME-115x115.webp)
![Confidenza: Daniele Luchetti e Domenico Starnone parte 3 Giunto alla terza trasposizione cinematografica dei libri dell’applaudito romanziere partenopeo Domenico Starnone, dopo La scuola: Ex cattedra-Fuori registro-Sottobanco-Solo se interrogato, tradotto sul grande schermo quasi trenta primavere or sono, e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Confidenza-115x115.webp)
![In dvd Volti coperti – Storia di un ultras di Stefano Calvagna Dopo aver resi disponibili per il mercato dell’home video i suoi Si vis pacem para bellum, Cattivi e cattivi e Baby gang, Digitmovies prosegue il proprio lavoro di diffusione su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Volti-coperti-Storia-di-un-ultras-115x115.webp)
![Spy x family – Code: White – anime… di agenti Spy x family – Code: White, diretto da Takashi Katagiri e Kazuhiro Furuhashi, è il capitolo cinematografico della popolare serie anime. Loid sta per essere sostituito nell’operazione Strix, ma fa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Spy-Family-Code-White-115x115.webp)
![Grande successo e tantissimo pubblico per la premiere romana di Iron Fighter di Claudio Del Falco Si è tenuta presso il multisala Adriano di Roma la premiere di Iron Fighter, fight / action movie che segna l’esordio dietro alla macchina da presa per l’attore e campione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IRON-FIGHER_12-Copia-115x115.webp)
![Ecco tutti i candidati del Vespertilio Awards 2024, premio dell’horror italiano Brando De Sica, Luna Gualano e Andrea Niada sono i registi le cui opere hanno ottenuto più candidature per l’edizione 2024 del Vespertilio Awards, premio dedicato al cinema horror e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2022/07/Vespertilio_Awards-115x115.jpg)
![“Onirica”: su Amazon Prime Video l’omaggio di Luca Canale Brucculeri al cinema di Dario Argento Amici di Mondospettacolo, voglio dare un consiglio a tutti voi che amate il cinema il cinema di Dario Argento. È in programmazione in questi giorni su Amazon Prime Video “Onirica”, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/180424351-51b17f84-f6dc-4441-b05a-19d0bcb57463-115x115.webp)
![Terza edizione per Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano Scoprire una strada indipendente al cinema italiano, nello specifico quella di genere fantastico. Questo l’obiettivo della rassegna cinematografica Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano, curata da Matteo Scarfò, Giuliano […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Body-Odyssey-115x115.webp)
![Iron fighter: arti marziali, auto veloci e vendetta per l’esordio registico di Claudio Del Falco L’attore e sportivo Claudio Del Falco debutta alla regia con il lungometraggio Iron fighter, interpretandone anche il protagonista che porta il suo stesso nome. Nel film è, appunto, un campione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Iron-fighter-115x115.webp)
![Un mondo a parte, il regista Riccardo Milani: “Come genitori dovremmo essere più riconoscenti verso gli insegnanti” “Un mondo a parte”, una pellicola cinematografica diretta dal regista Riccardo Milani che mette in risalto il ruolo degli insegnanti e quanto esso incida sul ruolo che essi svolgono nella […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Schermata-2024-04-19-alle-17.32.43-115x115.png)
![La Roma del 1943 rivive ne Il maritozzo, con Paolo Conticini e Martina Sissi Palladini È pronto per iniziare il suo percorso festivaliero Il maritozzo, cortometraggio ambientato nella Roma del 1943, alcuni giorni prima della deportazione degli ebrei dal ghetto della capitale. Una delicata opera […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Il-maritozzo_5-115x115.webp)
![Cilento, terminate le riprese del docufilm Ciak si gira “Ciak si Gira” è un progetto della Fondazione Monte Pruno in collaborazione con Dlivemedia diretta da Roberto Vargiu. “Ciak si Gira” è un docufilm, di cui sono appena terminate le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cineturismo1-115x115.webp)
![Lady Cobra – Una killer in blues: un esordio tra dramma psicologico e cinema di genere Fabio Giovinazzo esordisce nella regia di un lungometraggio dirigendo Lady Cobra – Una killer in blues. Un film dall’approccio teatrale che vede come protagonista una donna che vende fiori davanti […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LADY-COBRA_locandina-115x115.webp)
![La terza edizione di Indiecinema Film Festival sbarca alla Bottega dell’Attore! Il prossimo evento ufficiale riguardante Indiecinema Film Festival – Terza edizione, in programma Sabato 20 Aprile 2024 a partire dalle ore 21, avrà luogo presso una nuova e prestigiosa location: […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Indiecinema_1-115x115.webp)
![Mondospettacolo intervista il regista Davide Scovazzo Davide Scovazzo nasce a Genova nel 1980. Sceneggiatore e regista, laureato al DAMS, si definisce un autodidatta. Ha lavorato come aiuto regia, assistente alla regia e assistente di produzione per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/ScovazzoOr-115x115.webp)
![“De Amore et Obsessione”: scopri tutte le novità sul suo ultimo video Da venerdì 26 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “De Amore Et Obsessione”, il nuovo singolo di Subaru disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 10 aprile. “De […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG_5804-115x115.webp)
![Novella – Il singolo Grazie Tommaso Il brano della cantautrice sugli stores e nelle radio “Grazie Tommaso” è il nuovo singolo della poliedrica artista e cantautrice Novella, sui principali stores digitali e dal 12 aprile nelle […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Novella-1-115x115.webp)
![VEJO – Il nuovo singolo Rugiada Il brano dell’artista sugli stores e dal 10 aprile nelle radio “Rugiada” è il nuovo singolo della poliedrica artista VEJO, sui principali stores digitali e dal 10 aprile nelle radio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Vejo-1-115x115.webp)
![Aldo Diguerrino – Il nuovo singolo Io sono Aldo In radio il brano del cantautore trevigiano “Io sono Aldo” è il nuovo singolo dell’eclettico artista e cantautore Aldo Diguerrino, sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-Aldo-Diguerrino-2--115x115.webp)
![Esplorando l’Universo Musicale dei The Badly Behaved: Tra Synthpop, Cinematografia e Innovazione Sonora Benvenuti a un viaggio nel mondo unico e avvincente dei The Badly Behaved, una band che fonde con maestria elementi di synthpop ed electropop con ispirazioni cinematografiche e influenze multigenere. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Soulless-City-artwork-The-Badly-Behaved-MusicAlive.net_-115x115.webp)
![Mr Melt e Oyoshe – Due diamanti dell’Hip Hop Italiano insieme su Just Ice Dopo la pubblicazione del disco Justice per l’etichetta KML, Mr Melt, rapper romano e attivo ad Amsterdam ormai da anni, pubblica il video del primo estratto del disco. Il brano […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-Mr-Melt-115x115.webp)
![PignaEnd – Il singolo Dodi & Diana Il brano dell’artista dal 29 marzo nelle radio “Dodi & Diana” è il singolo dell’eclettico artista cantautore PignaEnd, già presente sui principali stores digitali e dal 29 marzo nelle radio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-1-115x115.webp)
![Illusione Postmoderna il nuovo singolo di Dario Rizzardi Da venerdì 26 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Illusione Postmoderna” il nuovo singolo di Dario Rizzardi. “Illusione Postmoderna” è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/COPERTINA-4-115x115.webp)
![Francesco Lattanzi: la bellezza non ha bisogno di maschere È l’unica cosa certa: la vera bellezza non ha bisogno di maschere. “Alla morte” – titolo duro nella forma ma tutt’altro che cattivo nelle intenzioni, è il ritorno in scena […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lattanzi3-115x115.png)
![Giuseppe D’Alonzo intervista su Mattinieri del tempo Fuori dal 8 marzo “Mattinieri del tempo”, il nuovo singolo di Giuseppe D’Alonzo. Dopo un lungo periodo acustico il cantautore torna con un pezzo rock dal retrogusto disco. Lo abbiamo […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/io-2-115x115.webp)
![Geepsity: ascolta il primo album ufficiale Eclettico Dal 24 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “ECLETTICO” (Kimura), il primo album di GEEPSITY. “Eclettico” è un album di nove canzoni accomunate da sonorità […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/in-radio-e-streaming-tutto-il-nuovo-singolo-di-geepsity-115x115.webp)
![Hullabaloo il disco d’esordio dei Tanz Akademie Da venerdì 26 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “HULLABALOO” (Overdub Recordings), il primo album dei TANZ AKADEMIE. “Hullabaloo” è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/COVER_tanz.akademie-115x115.webp)
![Giù: L’Arte di Trasformare il Dolore in Musica con Lacrime di Venere Il talentuoso artista e cantautore Giù ha lanciato il suo ultimo singolo “Lacrime di Venere” sui principali stores digitali, pronto a conquistare anche le radio nazionali. Con una produzione impeccabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Giu-2-MusicAlive.net_-115x115.webp)
![Soul – Il nuovo singolo Perdoname Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 29 marzo nelle radio “Perdoname” è il nuovo singolo del cantautore Soul, prodotto da Sintesy, sui principali stores digitali e dal 29 […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Foto-2-2-115x115.webp)
![Al Matis closing party con Jake La Furia Ultimo fine settimana stagionale per il Matis Club di Bologna, che si congeda dal suo pubblico con un doppio appuntamento: venerdì 26 aprile 2024 con il party Vida Loca e […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/27.04.24-jake-la-furia-@-matis-bologna-115x115.webp)
![Huracāne il nuovo album dei The Mayan Factor Dal 24 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Huracāne” (Overdub Recordings), il nuovo album dei The Mayan Factor. “Huracāne” è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/The-Mayan-Factor-HURA¯CANE-cover-115x115.webp)
![The Fabulous e Ralf Pic-Nic al Peter Pan Club È sempre festa grande al Peter Pan Club di Misano Adriatico, che si avvia nel migliore dei modi al suo finale di stagione invernale. Tre i prossimi appuntamenti da segnarsi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/peter-pan-the-fabulous-24.04.24-bis-115x115.webp)
![All’Amnesia Milano special guest il brasiliano Alok Il legame tra Amnesia Milano e i top dj e producer brasiliani è consolidato da anni, basti pensare alle serate che in passato hanno visto protagonisti Vintage Culture e Mochakk. […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/24.04.24-alok-guest-amnesia-milano-115x115.webp)
![Indira Paganotto Metamorfosi resident all’Amnesia Estate 2024: Indira Paganotto è pronta per tornare all’Amnesia di Ibiza, dove si prenderà cura della club room durante la one-night Metamorfosi di e con Joseph Capriati dal 19 luglio […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/paganotto-2024-bis-115x115.webp)
![Wretched dei Pierce Brothers Wretched – La Madre Oscura (The Wretched) è un folk horror statunitense del 2020, opera prima del duo di registi e sceneggiatori noto come The Pierce Brothers. I due fratelli […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/MadreOr-115x115.webp)
![Mondospettacolo intervista il regista Fabrizio La Monica Fabrizio La Monica nasce a Palermo nel 1990, inizia a girare corti e film per il web molto giovane. Nel 2017 inizia un sodalizio artistico con l’attore Ferdinando Gattuccio con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/FabrizioOr-115x115.webp)
![The Lodgers di Brian O’Malley “Come può il Fato essere in torto?” Ogni tanto anche in questi anni Duemila qualcuno decide di confrontarsi con l’horror gotico. C’è chi lo fa peggio, chi meglio. A quest’ultima […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LodgersOr-115x115.webp)
![Mondospettacolo intervista il regista Leonardo Barone 1976 Leonardo Barone nasce a Piombino (LI) il 1 dicembre del 1976 da Antonino Barone, operaio della Lucchini, e Serenella Ranieri, impiegata alle poste. 1980 – 1990 Sin da ragazzino […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/LeoOr-115x115.webp)
![Tenebra: l’oscuro viaggio di Anto nella mente dell’Orco “La Vita è solo Sofferenza. L’Orco Buio è dappertutto. Il Male è dappertutto” L’Italia, col suo cinema indipendente, non finisce mai di sorprendermi. Ogni giorno scopro nuovi esperimenti filmici, nuovi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/TenebraOr-115x115.webp)

![Jericho’s tail (La coda di Jericho): videointervista alla cam girl Silvia Lamberti Classe 1985, il nome di Silvia Lamberti è particolarmente conosciuto soprattutto tra i fan dell’hard, universo di cui è entrata a far parte a trent’anni. Pittrice professionista fino all’età di ventisette anni, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/SILVIA-LAMBERTI_2-115x115.webp)
![Jericho’s tail (La coda di Jericho): una clip esclusiva Scritto, prodotto, diretto e interpretato da Marcello Caroselli, Jericho’s tail (La coda di Jericho) è già da qualche settimana tra i nuovi titoli entrati a far parte della library di […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/JERICHOS-TAIL_5-Copia-115x115.webp)
![Su TecaTv Omicidio al cimitero, Il passaggio segreto e L’uomo col cilindro Da lunedì 13 Marzo 2024 la piattaforma TecaTv – di proprietà della Running Tv International – è diventata un canale streaming in abbonamento, per cui gli utenti possono accedere a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/Omicidio-al-cimitero-115x115.webp)
![15- 21 aprile: nuova settimana su Cusano CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 15 – 21 APRILE Un’altra settimana ricca di emozioni vi aspetta su Cusano Italia TV (canale 122 del Digitale Terrestre) […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/cusano-arte-115x115.webp)
![Bravissima, il Talent Show ideato e condotto da Valerio Merola, in onda Sabato 13 Aprile su Sky 913 e Canale Italia È il primo talent show della tv italiana e detiene ancora il suo primato dopo trentatre anni. Quando VALERIO MEROLA ideó il format nel 1991 e organizzó la prima edizione […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/04_12-VALERIO-E-PRESENTATRICI_1280-115x115.webp)
![Videointervista alla giovane conduttrice televisiva di Italian Green “Noemi David” Amici di Mondospettacolo oggi voglio proporvi una videointervista alla giovane conduttrice televisiva Noemi David. Noemi in questo momento è su Raidue fino a fine Aprile con “Italian Green” un programma in onda il sabato su Raidue, incentrato sul […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-28-at-7.34.35-PM-115x115.webp)
![la via dei ciliegi: il nuovo show di cucina giapponese è ora disponibile su Prime Video Italia Millennium Cinematografica presenta La via dei ciliegi, un viaggio on the road per l’Italia alla ricerca dei migliori ristoranti e delle migliori ricette dell’Hanami, usanza giapponese che consiste nell’osservare la […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/La-via-dei-ciliegi-115x115.webp)
![Presentata la fiction tv Margherita delle stelle, su Margherita Hack Tenutasi a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Margherita delle stelle, nuova produzione Rai Fiction – Minerva Pictures in onda su Rai 1 il prossimo 5 Marzo 2024, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/Margherita-delle-stelle_conferenza-115x115.webp)
![Cosa ci aspetta questa settimana su Cusano Italia Tv e Radio Cusano? CUSANO ITALIA TV E RADIO CUSANO CAMPUS: HIGHLIGHTS E ANTICIPAZIONI 05 – 11 FEBBRAIO Siamo pronti a guidarvi attraverso una nuova settimana ricca di emozioni, spettacolo e approfondimenti su […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/bagheera-cusano-115x115.webp)
![Su Prime Video la serie comedy Original italiana No Activity – Niente da segnalare No Activity – Niente da segnalare è la nuova esilarante serie comedy Original italiana in sei episodi tutti da ridere, disponibile in esclusiva dal 18 Gennaio 2024 su Prime Video, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/01/No-activity-115x115.webp)
![Contribuire alla cultura e alla scienza: un impegno condiviso con la Fondazione Alma Dal Co Quest’anno la Fondazione Aidr (www.aidr.it) ha scelto di sostenere la Fondazione Alma Dal Co invitando tutti coloro che fanno parte del proprio network a destinare il cinque per mille dell’IRPEF […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Alma--115x115.webp)
![Guerre e conflitti: come affrontarli nella scuola italiana Cosa ne pensa del conflitto tra Israele e Palestinesi? Ma quando finirà la guerra in Ucraina? Pensa che ci sarà la terza guerra mondiale? Sono queste le domande inquietanti che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Monica-Constantin-Fulvio-Oscar-Benussi-115x115.webp)
![Intervista ad Alexis Venere: la prima coach italiana nel mondo adult Alexis, in quanto coach di Ciaofan, potresti gentilmente spiegarci cos’è esattamente questa piattaforma e quali servizi offre? Ciaofan offre una vasta gamma di servizi per i creator nel settore dell’intrattenimento […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-15.46.36-115x115.webp)
![Shary Lorenzelli e i miei sogni nel cassetto Cara Shary, come stai? Benvenuta su “Mondospettacolo”. Ci racconti un po’ di te, che cosa fai nella vita? Nella vita, oltre a convivere e ad occuparmi della mia casa, lavoro […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/92de0955-94a5-4043-ad29-369ebebd91b5-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Gioia Giovannini Gioia Giovannini è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Gioia, benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex molto bene è un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-12.02.47-2-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: So.obe Sofia (So.obe) è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Sofia benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alex, tutto bene e grazie per […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-24-at-14.53.30-115x115.webp)
![Intervista ad Annalinda Barini professione: Fotomodella Amici di Mondospettacolo, sono molto felice di essere qui oggi per intervistare una delle più famose e talentuose fotomodelle del momento: Annalinda Barini. Conosciuta in tutta Italia per la sua […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/82372490_446340289580440_2174340967560118272_n-115x115.webp)
![Speciale Curvy Model: Lulù Amici di Mondospettacolo, sono qui oggi per presentarvi Lulù, una modella curvy che ha conquistato il cuore di tutti i giudici del concorso Miss Curvyssima 2023, diventando una delle finaliste […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-14.01.42-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Laura Lezza “La_petitemodel” Laura Lezza è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Laura benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao a tutti! Sto molto bene grazie! […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Lauracoppetite-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Ramona Fella Ramona Fella è la Fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Ramona benvenuta su Mondospettacolo. Ciao Alex e grazie per avermi proposto questa intervista […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-21.47.38-1-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Daniela Casali Daniela Casali è la fotomodella protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Daniela benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Ciao Alessandro. Sto bene grazie, a […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-00.09.40-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Anastasia Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per intervistare “Anastasia”, una fotomodella Italo/Russa di grande successo. Anastasia, grazie per aver accettato di parlare con noi. Per cominciare, vorrei sapere quali sono […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-12-at-22.23.02-115x115.webp)
![Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinata Miriam Tirinzoni: L’Esclusiva Essenza della Moda Raffinat Miriam Tirinzoni Fashion Brand si distingue nel panorama delle consulenze d’immagine, offrendo un servizio esclusivo dedicato alle aspiranti Miss del futuro. Dall’eleganza intramontabile […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/Miriam-Tirinzoni-foto-2-115x115.png)
![Cristina Barka: Le sue passioni, i suoi sogni…. “Mi chiamo Cristina Barka, ho 21 anni, sono di origine tunisina e vengo dalla zona di Genova che prende il nome di “Valbisagno” dall’omonimo torrente che vi ci scorre. Le […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/9225-115x115.webp)
![Le Bellissime di Mondospettacolo: Vanessa Kaos Amici di Mondospettacolo, oggi sono qui per proporvi una nuova videointervista alla bellissima e simpaticissima Fotomodella e Sexy Star “Vanessa Kaos”. Vanessa ha delle grandi novità da raccontarci, ma ora […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/VanessaCop-115x115.webp)
![Le Bellissime di Mondospettacolo: Giulia Daniela Soponariu Amici di Mondospettacolo, oggi ho l’onore di presentarvi Giulia Daniela Soponariu una giovane e talentuosa artista, che ha già alle spalle una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di una […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/giucop-115x115.webp)
![Le modelle di Mondospettacolo: Ludovica Anna Iacobellis Amici di Mondospettacolo, sono lieto di essere qui oggi per intervistare “Ludovica Anna Iacobellis” una giovanissima modella. Come sapete, la moda e il mondo dello spettacolo sono due industrie in […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-27-at-12.23.24-AM-1-115x115.webp)
![Sara Banfi: “Una Fotomodella di Successo”! Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Sara Banfi una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che tutti voi siete curiosi […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-02-24-at-22.34.36-2-115x115.webp)
![Polina Ferari fotomodella, personal trainer si racconta a Mondospettacolo Polina Ferari fotomodella russa per “Mondospettacolo” “Sono Polina Ferari, personal trainer e fotomodella. Laureata in regia cinematografica e giornalismo a Mosca e a Milano ho fatto la scuola AIPT, accademia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/03/ok1-115x115.webp)
![L’Erotic Model Eva Kisimova “Strega Erotica” ci video racconta la sua esperienza a: “La Zanzara” “La Zanzara” è un programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto dal giornalista Giuseppe Cruciani con la collaborazione del collega David Parenzo. Verso la parte finale della divertentissima trasmissione, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-17.39.09-115x115.webp)
![Intervista a Karen De Pedrina: ” Modella ufficiale Sanremo 2024 “ Amici di Mondospettacolo, Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi “Karen De Pedrina” una fotomodella di successo, una donna che incarna bellezza, eleganza e professionalità. Sono certo che […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/karen1-115x115.png)
![Intervista alla modella Paola Star Paola Star modella di Lucca Vuoi presentarti ai lettori di “Mondospettacolo”? “Mi chiamo Paola, di Lucca, in arte Paola Star, mi ritengo una persona normalissima, una mamma, una moglie come […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/1-5-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Eleonora “sensual_plum” Eleonora è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Eleonora benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Grazie per il tuo invito e rivolgo un […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20231128_080556_717-115x115.webp)
![Le Fotomodelle di Mondospettacolo: Erica Castagnoli Erica Castagnoli è la protagonista del nostro editoriale di oggi, conosciamola insieme con questa intervista! Ciao Erica benvenuta su Mondospettacolo, come stai innanzitutto? Buongiorno a tutti e grazie per questa […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-22-at-14.33.50-115x115.webp)
![Come funziona il lavoro della Cam Girl? Lo abbiamo chiesto a baby.red3000 Una cam girl, nota anche come model di webcam o performer di webcam, è un lavoro che consiste nell’esibirsi in diretta su internet tramite webcam, solitamente in siti specializzati, con […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-21-at-13.16.20-3-115x115.webp)
![Video intervista a Valeria Lupi una delle Adult Content Creator più richieste d’Italia Amici di Mondospettacolo, il nostro editoriale di oggi è dedicato alla Adult Content Creator Valeria Lupi. La Supersexy Curvy romana, dopo aver iniziato la sua carriera come fotomodella curvy, ha […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-18-at-20.30.04-1-115x115.webp)
![L’Italia vince il Mondiale (del sesso) con la coppia Mary Ryder e Capitano Eric Amici di Mondospettacolo, oggi voglio parlarvi di un argomento un po’ insolito ma che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo: i campionati mondiali del sesso. Sì, avete capito bene, […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-10.39.58-115x115.webp)
![La Madrina della 4^ edizione del Veneto Sex: Lisa Amane Amici di Mondospettacolo, dal 17/05/2024 al 19/05/2024 si terrà (presso il prestigiosissimo locale “New 1000 lire” di Preganziol) la 4^edizione del Veneto Sex. Tra le tantissime pornoattrici che parteciperanno a questa Kermesse […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-06-at-18.03.58-115x115.webp)
![Mondospettacolo video intervista la Adult Content Creator “Fattolandia” Amici di Mondospettacolo, oggi voglio proporvi la video intervista di Irene “Fattolandia” una promettente Adult Content Creator. Vediamo di conoscerla insieme. Ecco la video intervista. Irene Fattolandia sui Social https://linktr.ee/Fattolandia […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/04/fattolandiacop-115x115.webp)
![Amandha Fox realizza un calendario per una guida più sicura! Amandha Fox la venere polacca, realizza un calendario per sensibilizzare alla guida sicura! La regione Puglia e la città di Treviso sono state le location scelte per la realizzazione del […]](https://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2024/02/Amandha-Fox-calendario_2024_3-115x115.webp)
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.